I migliori film (in ordine sparso) del 2023 secondo Stranger Than Cinema, selezionati esclusivamente tra quelli distribuiti in Italia (al cinema, in streaming o con formula ibrida) tra l’1 gennaio 2023 e il 18 gennaio 2024. Sono quindi esclusi i film passati ai festival che non hanno ancora ricevuto regolare distribuzione e, al contrario, sono inclusi film con anno di produzione precedente, ma distribuiti in Italia nel 2023.
Pacifiction
Il corpo del sovrano: questo è stato il soggetto del penultimo film di Albert Serra, La morte di Luigi XIV (2016), ancorato alla lenta agonia di un fisico in decadimento che era quello di Jean-Pierre Léaud, e quindi anche un po’ necessariamente del cinema stesso. Un corpo simbolicamente carico di potere, scrutato a lungo e messo alla prova di una crudele afflizione fisica. Pacifiction è in fondo lo stesso film, anche se tutto è certamente un po’ meno mitologico, un po’ meno divino. Benoît Magimel (meno leggendario di Léaud, ma altrettanto magnetico) presta le sembianze a De Roller, un misterioso funzionario con l’aria di un re coloniale, che governa - o meglio, regna - in modo vaporoso, immateriale (non ha un ufficio, non ha documenti da firmare, non ha una vera e propria missione e si limita a saltare da una discussione informale all’altra), su un’isola addormentata dove si rincorrono le voci di una ripresa dei test nucleari. Un film assolutamente conradiano, nel senso più profondo che si possa dare all’aggettivo, vale a dire, non solo per le semplici ragioni di esotismo – con cui Serra gioca in maniera grottescamente manierista, fino ad esoticizzare anche la carta da parati - ma perché dietro l’estetizzazione, Pacifiction cerca un incontro impossibile con ciò che non si può vedere: ciò che si cela dietro le palme e i tramonti, ciò che si nasconde sotto le onde (il MacGuffin è un sottomarino nucleare), ciò che si nega dietro il linguaggio vuoto della politica e sotto le manovre del potere. Probabilmente, e qui sta la tragedia: niente.

Inu-oh
Gli innovatori del teatro Nō raccontati nel nuovo film di Masaaki Yuasa - Inu-Oh e Tomona - sono i T. Rex del Giappone feudale in un delirio di anacronismi che cresce fino al culmine di un film che si spoglia di tutto, semplificando il tratto e riducendo al minimo la narrazione, per diventare finalmente solo ritmo. Entrambi imperfetti e marginali (uno cieco, uno deforme), i due si conoscono durante un evento musicale e la loro amicizia viene favorita proprio dalle loro rispettive deformità (dal momento che uno non può vedere l’aspetto spaventoso dell’altro e quindi decide di non scappare come fanno tutti). Formano un gruppo e mettono su qualcosa di molto simile a quella che oggi verrebbe definita la tournée di una grande rock band. Uno dei due è pronto a compromettersi ed eventualmente a rinunciare agli elementi più sovversivi dei loro brani, uno invece vuole emanciparsi dal proprio passato attraverso la musica e non è disposto a concedere nulla. Yuasa comprende perfettamente il legame essenziale tra performance e corpo e così il fisico pieno di deformazioni del leader (quello disposto a normalizzare la propria musica se richiesto dal potere costituito) ad ogni brano esplode tornando normale, diventando progressivamente un corpo addomesticato, sempre più utile al sistema e sempre più conciliante. È il successo e il consenso a mutarlo, a uniformarlo rimuovendo tutti gli elementi che ne determinavano l’iniziale aspetto disturbante.
Leggi QUI la recensione completa.

Rewind & Play
Gli austeri, distinti e colti ammiratori francesi di Thelonious Monk erano probabilmente poco interessati alla sua musica e più a lui, alla sua leggenda, alla sua immagine eccentrica di “freak” dal talento inafferrabile e dal quale ci si poteva aspettare qualsiasi intemperanza. È quello che emerge dallo straordinario documento storico che è Rewind & Play di Alain Gomis, basato su scene inedite di uno spettacolo registrato per la tv francese nel 1969. Un’eccezionale indagine sul modo in cui la televisione, più in generale l’audiovisivo, mostra la realtà per quello che non è: ciò che ci aspettiamo da Monk è il mito che si è creato attorno a lui e tutto ciò che non rientra in quello schema sembra non avere alcun interesse per le persone che lo circondano nella sua trasferta parigina. Un artista ridotto ad una figurina senza vita, quella di un uomo nero che è rispettato per il suo status di genio fuori dagli schemi, ma che tuttavia rimane un uomo di colore perso in mezzo ad una folla di bianchi che sembrano non capire fino in fondo cosa stiano vivendo (e ascoltando). I registi, ossessionati dalla perfezione tecnica delle inquadrature, moltiplicano le riprese, ovviamente dolorose per Monk, a cui viene posta dieci volte la stessa domanda stupida e aneddotica. Ma alla fine, quando ci si ferma finalmente ad ascoltare e ci si libera dal circo mediatico, sembra di essere soli davanti al miracolo di un gigante esausto, sull’orlo delle lacrime, ma stoico, fatalista, abituato a essere considerato esclusivamente per le sue stranezze, e a quelle immagini mute, strazianti, di sua moglie Nellie, nascosta dietro ai suoi occhiali, che lo accompagna ovunque e per la quale Monk ha composto una delle sue canzoni più belle: Crepuscule With Nellie.

Laggiù qualcuno mi ama
Massimo Troisi è stato uno dei grandi maestri del vuoto. Così Enrico Ghezzi, in maniera come al solito definitiva, celebrò nel 1987, durante una puntata del programma Va Pensiero, un cinema, quello di Troisi appunto, fatto di monologhi inconcludenti, frasi appena accennate, “parole smozzicate” e frammenti che trovavano il loro senso proprio nell’incompiutezza che chiamava sempre altro, che richiedeva sempre di proseguire il discorso. Ed è da questa stessa intuizione che Mario Martone sembra aver cominciato a comporre-scrivere il suo documentario Laggiù qualcuno mi ama, senza l’arroganza di voler riempire i tanti “vuoti” nella poetica di Troisi, di esplicitare tutti quei non detti che ne costituivano la potenza e il fascino, bensì mosso da una genuina voglia di far “parlare l’archivio”, di riflettere (su) Troisi attraverso l’unico prisma possibile che è quello di Troisi stesso, delle sue parole, delle sue immagini, dei suoi appunti sul taccuino. Schegge, frammenti taglienti e difficili da maneggiare, che trafiggono un cinema che arriva sempre tardi, nel suo essere inconsapevole passato, evento già accaduto, negazione del movimento e, allo stesso tempo, paradossale riproposizione della vita (anche con i film, come con i libri, non si può mai stare al passo della loro produzione, parafrasando una celebre frase de Le vie del signore sono finite). Martone, nel suo tagliare, ricucire, interrompere e riavviare le scene più memorabili della filmografia di Troisi, esaspera questa crepa, l’impraticabilità del linguaggio, e rileva così il vero battito di quello stare al mondo (e sullo schermo) programmaticamente inadeguato e altero.
Leggi QUI la recensione completa.

Ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice
Mario Martone “utilizza” la figura di Mimmo Jodice, grande sperimentatore del mezzo fotografico in un periodo in cui la fotografia era prevalentemente strumento per indagini documentaristiche, per raccontare come la città di Napoli - le persone che la popolano, le sue architetture, la stratificazione ben visibile di ere e civiltà - possa educare lo sguardo di un artista (quindi anche il suo, di Martone) e formare una sensibilità rispetto al reale che non potrebbe nascere uguale in nessun altro luogo del mondo. È Napoli, più precisamente “l’estuario del tempo” che accoglie il visitatore che si addentra per la prima volta nel quartiere Sanità (rione a cui il regista ha dedicato molta della sua filmografia), ad aver spinto Jodice a compiere, con la sua arte, un viaggio nella memoria che inizia dapprima con i reperti delle civiltà antiche, poi approda al Mediterraneo, dove il tempo e la storia sono assenti per la predominanza indiscussa del mito, e si sviluppa negli anni Ottanta con una sottrazione ulteriore delle figure dallo spazio: il paesaggio si sostituisce all’uomo, in una metafisica utile a contenere l’imbarazzo verso una modernità avvertita come inquietante e spersonalizzante. Come nel documentario su Troisi, Martone cerca il femminile nell’opera di Jodice (e quindi il contributo della moglie Angela Salomone) e, in una contemporaneità in cui si scattano foto e si producono immagini in quantità impossibili poi da elaborare, si concentra sul lavoro di un maestro che ancora si concede il lusso di impiegare tre giorni per un singolo scatto.

Rheingold
La preoccupazione del cinema di Fatih Akin, nonostante gli alti e bassi della sua carriera e l’ormai sempre più distratta considerazione di chi lo aveva incensato ai tempi de La Sposa Turca e di Soul Kitchen, è rimasta la stessa: le tribolazioni di personaggi provenienti da una Germania “multikulti”, che questo figlio di immigrati turchi ha sempre posto al centro della sua indagine, consegnando un ruolo centrale alla musica - specialmente quella underground e nata dall’esperienza delle minoranze etniche - come catalizzatrice di disagi, aspirazioni e istanze. Una poetica assolutamente coerente con il progetto di questo Rheingold: biopic gigantesco nella scala e nelle ambizioni sul rapper tedesco ed ex criminale Xatar (al secolo Giwar Hajab), nato sotto le bombe del conflitto tra Iraq e Iran (qui raccontato con l’epica del war movie e non relegato a semplice nota biografica) da profughi curdi che lo hanno cresciuto nella musica classica. Un racconto di grande intensità sull’esigenza di espressione, il desiderio di migliorare la propria condizione sociale e sul culto della propria personalità: esattamente le componenti che oggi animano gli immaginari dei rapper più noti e apprezzati a livello mondiale. Akin lo mette in scena seguendo tutto il canovaccio della grande ascesa criminale come la racconta e l’ha sempre raccontata il cinema americano, adattandolo perfettamente allo scenario tedesco, ma soprattutto facendo emergere tra le pieghe della narrazione il modo in cui sia stato possibile maturare una propria “sensibilità” artistica nei risvolti di una vita di marginalizzazione, criminalità ed eccesso.

Fallen Leaves
Aki Kaurismäki, da almeno vent’anni, gira sempre lo stesso (meraviglioso) film, con gli stessi schemi, gli stessi personaggi perdenti, la stessa estetica rock decadente e gli stessi vecchi successi radiofonici europei tradotti in finlandese. Ma stavolta c’è un romanticismo che lascia senza fiato nella sua capacità di sintetizzare tutto con un gesto. Una fiducia incrollabile nel lieto fine. Fallen Leaves è infatti un white melodrama di sirkiana memoria al contrario, dove tutte le disgrazie che accadono ai due protagonisti anziché separarli fanno in modo che questi si ritrovino sempre insieme, con un sentimento ogni volta più chiaro e più potente. I due protagonisti vivono nella contemporaneità, ma con gli strumenti (vecchi cellulari, internet point a gettone) e le abitudini (la radio anziché la televisione, i messaggi su carta) degli anni Novanta. Di tanto in tanto si sintonizzano sull’oggi attraverso una emittente radiofonica che trasmette in tempo reale notizie sull’invasione russa dell’Ucraina, da commentare con un sospiro di rassegnazione o con qualche timida esclamazione (e solo perché i continui resoconti bellici impediscono loro di ascoltare la musica in radio). Ogni elemento visivo contribuisce alla creazione di un sentimento sempre crescente di estraneità e anacronismo: nel mondo reale, la sopravvivenza del protagonista è un’eventualità utopica. E così il coronamento di quel sogno d’amore: un’inverosimiglianza che solo il cinema può assumere in sé. Ansa e Holappa sono reali e fittizi insieme: sono proletari in assenza del proletariato, soli in assenza di un’identità collettiva, abbandonati in una fascia d’età che è quella in cui nessuno si prende più cura di te (troppo grandi per essere accuditi, troppo giovani per essere assistiti). Ancora una volta, quindi, il cinema di Kaurismäki trova nella solidarietà e nel mutuo soccorso le uniche vie praticabili per arrivare sani e salvi a domani.
Leggi QUI la recensione completa.

Spider-Man: Across the Spider-Verse
Questa volta l’influenza di Jeff Koons in Across The Spider-Verse, solo immaginabile e ipotizzabile nel primo film, viene finalmente esplicitata, rendendo evidente il debito dei suoi autori (Phil Lord e Christopher Miller) rispetto a quell’idea di esplorare il significato delle immagini e delle icone pop in un’epoca satura di media e così la conseguente crisi della rappresentazione, scandagliata attraverso un linguaggio visivo che dialoga sia con la pubblicità che con l’arte più elevata, che sfida le barriere tra cultura popolare ed élite collocando immagini familiari in composizioni astratte e fuori contesto. Lord e Miller prendono il mito del supereroe, nelle sue svariate declinazioni archetipiche, per rifrangerlo continuamente in un immenso gioco di specchi, rimandi e riverberi tra multiversi (e metaversi). Attraverso l’utilizzo di stratagemmi visivi che provengono dal mondo della tipografia e non da quello del cinema (seminale è stato, nel primo film, l’uso dell’aberrazione cromatica per indicare la profondità di campo), gli animatori passano in rassegna tantissime tecniche di stampa (con le loro inevitabili imperfezioni) per poi inventarsi un loro equivalente cinematografico. Di Koons, inoltre, l’animazione di questo secondo film richiama la dialettica tra controllo e caos sempre presente nelle opere dell’artista statunitense, che torna indietro fino alla cultura figurativa barocca di Bernini: il drappeggio drammatico ed espressionista dell’Estasi di santa Teresa d’Avila o ancora il pelo del cane a tre teste del Ratto di Proserpina, esempi in cui il controllo totale sulla scultura è in tensione con il movimento vorticoso del materiale, che sembra prendere il sopravvento sulla volontà dell’autore, imponendo autonomamente una propria direzione e una propria traiettoria. In linea con quella lezione, il potere travolgente di Across The Spider-Verse rimane, anche in questo caso, l’eterogeneità sfrigolante della sua animazione, la difficoltà nel rimanere nei contorni indicati, l’energia elettrizzante che riesce a trasmettere nel corpo filmico.
Leggi QUI la recensione completa.

Mission: Impossible - Dead Reckoning
La prima metà di Dead Reckoning, penultimo episodio di una saga che si concluderà nell’estate del 2024, non assomiglia affatto a un passaggio preliminare e non si astiene in alcun modo dal farsi atto conclusivo, riassumendo quasi trent’anni di Mission: Impossible (e quindi di cinema d’azione in generale) alla ricerca della sua quintessenza. Nel suo essere così ostinatamente vintage, in un prologo depalmiano che riposiziona le lancette dell’orologio alla fine degli anni Novanta, compie un’operazione simile (ma migliore) a quella di Indiana Jones e Il quadrante del destino, ponendosi orgogliosamente fuori dal tempo, anacronistico nella sua ostentata classicità. Romantica è l’idea, per celebrare la fine della saga (ma lo sarà davvero?), di tornare alle origini, citando le atmosfere del primo capitolo, con il duello sul ponte (là era Praga, qui Venezia), poi l’assalto al treno e presentando il sorprendente come-back, a 27 anni di distanza, del direttore dell’IMF Eugene Kittridge (Henry Czerny, assente nei cinque capitoli di mezzo). Il film, nonostante prosegua nel rimodellare il suo eroe su modelli sempre meno cool e desiderabili, insiste nel mantenere il sostanziale anonimato, l’unidimensionalità dell’agente Hunt, tutt’uno con le avventure keatoniane di cui è protagonista, probabilmente ancora inconsapevole di essere alle ultime battute della sua carriera cinematografica. Gli indizi della sua imminente fine, semmai, si possono cogliere nei flash-back dei capitoli precedenti, nella vaporizzazione delle questioni narrative, nell’avanzare di un nemico immateriale dalle intenzioni insondabili, nella progressiva spersonalizzazione dei personaggi secondari e nel divenire archetipico (decisamente più del solito) del racconto.
Leggi QUI la recensione completa.

Io Capitano
Scegliendo di raccontare la traversata dei migranti come una specie di road movie, facendone una storia di avventura (anche se tragica e dolorosa) e di amicizia, Matteo Garrone ha avuto la possibilità di sublimare il metodo di lavorazione che ha sempre adottato, di perfezionarlo e di renderne evidente l’efficacia, raggiungendo una naturalezza (di recitazione, narrazione e ritmo) che altrimenti sarebbe stato difficilissimo ottenere. Facendolo, accompagna l’emergere fragoroso della violenza (che in un racconto come questo è inevitabile, quasi doveroso, raccontare) con una regia sempre più dimessa, facendo in modo che la scena più feroce, quella che sarebbe facilissimo enfatizzare ed esasperare, venga spogliata di qualsivoglia tipo di clamore, caratterizzata solo da un pervasivo senso di insuccesso e fallimento. In questo viaggio di “disobbedienza” rispetto ai consigli della propria famiglia (evidente il riferimento al precedente Pinocchio), i due giovani cugini senegalesi - gli emergenti Seydou Sarr e Moustapha Fall, da cui Garrone tira fuori il meglio - condividono paure, gioie e dolore, accogliendo in sé tutte le emozioni contrastanti che un’epopea così totalizzante suscita nell’animo di chi la compie. La loro casa, il Senegal, è rappresentata nel film come un luogo di luce, colmo di colori e di affetti. È un pieno che dà avvio al loro viaggio, che lentamente scolorisce a mano a mano che i due protagonisti se ne allontanano. Io Capitano diventa così la storia dell’ingenuità di chi ha tutta la vita davanti e la voglia di costruirsela seguendo i propri sogni e le proprie ambizioni, schiacciata dalla tragica realtà che conosciamo dall’altro lato dello schermo, fatta di corruzione, violenze, mafia, prigionia. Garrone gioca costantemente su questa impossibilità per lo spettatore di partecipare interamente alla felicità, anche se momentanea, dei protagonisti del suo film: li vediamo felici per aver scampato un pericolo, per aver incontrato un nuovo amico sulla strada, per aver trovato un posto sicuro dove passare la notte, ma non riusciamo mai davvero a godere anche noi di quegli attimi di sollievo. Fugaci momenti di serenità, che i due attori rendono dolcissimi e teneri, che non trovano mai una completa aderenza dello spettatore, che già sa - a differenza loro - le insidie e le minacce che aspettano i due ragazzi nella tappa successiva del loro viaggio.
Leggi QUI la recensione completa.

Il faraone, il selvaggio e la principessa
Da un cortometraggio all’altro, Michel Ocelot ne Il faraone, il selvaggio e la principessa sembra riesplorare le sue stesse immagini. Sublima il suo cinema di profilo e di orizzontalità bidimensionale andando alle origini di quella iconografia (ovvero l’Egitto, sotto la spinta del Louvre), fa rivivere il magnifico teatro di ombre di Principi e principesse e di Ivan Tsarevich, fino ad approdare ad una tridimensionalità più contemporanea, vicina a quella di Azur e Asmar, nell’ultima delle tre storie che compone il film. Si ha così l’impressione di aver risalito in fretta e furia tutta la filmografia del cineasta, in un compendio di immagini digitali che rendono evidente ancora una volta la bellezza immateriale del suo meticoloso lavoro di artigianato. E si prova un senso di profonda vertigine davanti alla capacità dell’immagine al computer di rievocare civiltà, epoche e paesi con grande precisione e con una raffinatezza di dettagli che avvicina ogni composizione digitale a quella delle tessiture a mano, del pizzo e degli arazzi.

The Old Oak
Ancora una volta il senso di tutto il cinema di Ken Loach sta nell’utilizzo delle dissolvenze a nero. Quelle dissolvenze a nero che in Io, Daniel Blake venivano utilizzate dal regista come dimostrazione di pietà nei confronti del protagonista, di fatto impedendo allo spettatore di indugiare troppo sulla sua sofferenza, con il rischio di provare non più compassione ma commiserazione, e che invece in Sorry We Missed You arrivavano quando tutto ciò che c’era da vedere era già stato visto, inghiottendo i personaggi dai margini dell’inquadratura nel buio risolutivo di una giornata che si chiudeva per ricominciare uguale a sé stessa. Adesso, in The Old Oak, lo schermo nero serve da strumento di riflessione, spazio in cui nulla accade che consente allo spettatore di ricomporre i pensieri su ciò che ha appena visto, e allo stesso tempo facilita, per ellissi, la “ricomposizione” tra comunità apparentemente in contrasto: quella dei rifugiati siriani, arrivati nella periferia di Durham, e quella dei cittadini inglesi poverissimi, che individuano negli stranieri un nuovo capro espiatorio per la loro condizione di solitudine e svantaggio. Al riemergere dell’immagine dal buio, troviamo - forse in controtendenza rispetto agli ultimi pessimistici film di Loach - una collettività più coesa, inclusiva, numerosa. Chi avevamo conosciuto come ostile ai nuovi “concittadini”, lo riscopriamo su posizioni differenti, con una mutata sensibilità e una maggiore predisposizione ad accogliere “l’altro”. Come se, appunto, quei secondi di nero avessero dato la possibilità - fuori dall’inquadratura - di ricucire le ferite e ponderare meglio le proprie opinioni, indagare meglio le origini del proprio malcontento e delle proprie frustrazioni.
Leggi QUI la recensione completa.

Rodeo
Nel cinema d’autore francese c’è sempre stata una lunga corrente di film che hanno raccontato l’esplosione della violenza e del furore giovanile nei modi più eclatanti. Film su di una gioventù disperata, che vanno da La Fureur de vivre a Elephant, passando per I 400 colpi e L’odio: modelli aurei rielaborati oggi con uno spiccato gusto per la violenza drammatizzata e ritualizzata e per un’estetica pesantemente influenzata dalle mode del tempo (sia musicali che sartoriali), oltre che per una messa in discussione degli stereotipi di genere. Si pensi ai film del duo Jonathan Vinel e Caroline Poggi, all’opera prima di Julia Ducournau o, appunto, a questo bellissimo Rodeo di Lola Quivoron. Basato su Au loin Baltimore, cortometraggio che aveva realizzato nel 2015 dopo essersi diplomata a La Fémis, il film racconta la storia di Julia, giovane donna squattrinata che si avvicina al mondo estremamente maschile del cross-country. Ciò che colpisce subito è l’estrema gioia che accompagna lo svolgersi del film, che passa anche attraverso i colori sgargianti degli abiti e le carenature delle motociclette, filmate con l’ausilio di un formato quasi cinemascope che conferisce all’avventura un respiro epico da epopea di frontiera. Fare un primo film vuol dire scaldare e sfiorare l’asfalto, rischiare di affermare una propria personalità, giocarsela, proprio in mezzo alle bande di maschi (in Francia come altrove).

Bottoms
Perdere la verginità prima di entrare al college: questo pitch perfettamente canonico (Porky’s, American Pie, Supergrave, Booksmart, fino al sorprendente Super-bourrés, uscito quest’estate in Francia...), esposto in un prologo semi-improvvisato tanto bizzarro quanto esilarante, prende rapidamente in Bottoms una piega inaspettata quando si comincia a capire la strategia pensata dalle due giovani protagoniste per raggiungere i propri scopi: mettere in piedi un fight club. Il fatto che PJ e Josie non abbiano la minima abilità di combattimento non impedisce loro, da brave “amanti ignoranti”, di buttarsi a capofitto in sanguinose sessioni di pugilato che le renderanno le “lesbiche brutte e senza talento” - come le chiamerà il preside della scuola - ma finalmente popolari. Bottoms orchestra l’incontro esplosivo tra Monique Wittig e Jacques Rancière in un trionfo di comicità che evoca il Cry Waters di John Waters. Già Shiva Baby aveva consacrato il talento di Emma Seligman: girato per una miseria e ambientato durante un rituale funebre ebraico, quell’adattamento del suo cortometraggio di laurea (alla NYU) era stata l’occasione per regolare alcuni conti famigliari. L’attrice Rachel Sennott, eccezionale controfigura della regista nella finzione cinematografica era già lì. Ma è Ayo Edebiri (rivelata dalla serie The Bear) che qui impressiona e splende nel ruolo di Josie.

Trenque Lauquen
Storie raccontate a voce, in radio, nei libri, sui biglietti, disseminate come in una caccia al tesoro lungo le strade imprevedibili di un road movie labirintico e travolgente, frutto della visione comunitaria del formidabile collettivo argentino El Pampero Cine, a cui si deve il laboratorio narrativo e formale più ambizioso di questi ultimi anni (La Flor, 2018). Per comprendere questa nuova, eccitante e romanzesca opera è necessario accettare di giocare con la metafora botanica, una scienza a cui il gruppo composto da Mariano Llinás, Laura Citarella, Agustín Mendilaharzu e Alejo Moguilansky è tanto affezionato e che anche qui occupa un ruolo primario. Se la precedente produzione era stata concepita come un fiore, di cui ogni episodio avrebbe costituito un petalo, Trenque Lauquen è, invece, la sua intricata rete di radici. Il film prende le mosse da un ragionamento narrativo estremamente semplice: come molte opere che hanno spinto in avanti i limiti del cinema del loro tempo per restituire un’esperienza fino a quel momento inedita (L’Avventura, Vertigo, Mulholland Drive, solo per citarne alcuni), anche qui l’origine del racconto è un caso di scomparsa. Due uomini stanno guidando per la città di Trenque Lauquen e stanno cercando una donna. Uno è il suo coniuge, l’altro è il suo collega. L’architettura filmica evoca in più momenti I Misteri di Lisbona di Raoul Ruiz, nel modo in cui la parola è organizzata come forza motrice della narrazione e nel costante ribaltamento di generi ad ogni nuovo bivio spazio-temporale.

Sister Death
Non c’è forse una cinematografia nazionale in Europa capace di prendere sul serio il genere horror come quella spagnola. Paco Plaza, uno degli autori più celebri e apprezzati del filone orrorifico ispanico, con Sister Death segue alla lettera la lezione dell’elevated horror americano della A24 - adotta l’aspect ratio 4:3, la fotografia raffinata e una elegante austerità compositiva delle immagini - per declinarla alla propria maniera, alimentando quell’immaginario con i temi e le ricorrenze visive che da sempre agitano il suo cinema di possessioni e corpi che sfuggono al controllo di chi li abita. L’incontro tra una concezione del genere più metaforica e astratta, che lavora con le suggestioni più che con la messa in scena esplicita, con una concezione invece più classicamente fulciana (europea), di effetti speciali realizzati dal vero e grand guignol, è decisamente affascinante. Film d’autore ben nascosto sotto le mentite tonache di un infestato prodotto mainstream da consegnare alla macelleria dello streaming, pieno zeppo di rimandi e citazioni a quel suo ingiustamente snobbato predecessore spirituale che era Veronica.

Animali Selvatici
Nel villaggio della Transilvania in cui si svolge l’ultimo film di Cristian Mungiu, dal titolo emblematico di R.M.N, che è sia acronimo che indicazione toponomastica, non si parla solo romeno, ma anche l’ungherese e il tedesco. Persino il francese, residuo di una influenza europea, e l’inglese, la lingua globale per eccellenza. Ma in quella che appare una situazione ideale, di pacifica convivenza, di conquistato multiculturalismo, ogni lingua segue in realtà una precisa gerarchia. Dire “ti amo” in ungherese non implica l’assunzione di una responsabilità come dirlo in romeno. Chi è capace di passare con disinvoltura da un idioma all’altro, è disposto a farlo “solo quando serve” e quando la situazione lo richiede. L’arrivo di alcuni impiegati dallo Sri Lanka, assunti da un locale panificio grazie a dei finanziamenti dell’Unione Europea, solleva l’indignazione degli abitanti del villaggio e scoperchia il razzismo che era stato solo momentaneamente nascosto sotto il tappeto (il paragone, fatto sempre con accezione negativa dalla popolazione, è immediatamente quello con “l’invasione dei rom”). In questo contesto, un bambino di otto anni che non parla, figlio di uno dei tanti protagonisti di un film corale pensato per non avere un punto di caduta facilmente identificabile, sembra più il simbolo di una presa di posizione, di un’attesa consapevole, piuttosto che di un mutismo patologico da far verificare da un medico. Quello di Mungiu è un film profondamente pessimista, ma anche capace di indicare senza esitazione dove riporre quel poco di fiducia che rimane. Nell’Unione Europea, a cui si devono le possibilità di crescita e di scambio culturale. Nelle donne, che appaiono quasi sempre risolute e gestiscono l’unica reale attività economica del villaggio. Nelle future generazioni, terrorizzate dalla violenza e non virilmente affascinate da essa. Tutto questo appare evidente in una straordinaria sequenza collettiva, vera chiave di decodifica di un film che invece si chiude nell’ambiguità di un misticismo che disarma e rende palese l’impotenza davanti alle sfide e all’irrazionalità del presente.
Leggi QUI la recensione completa.

As Bestas
In un villaggio galiziano, una coppia francese vuole trasformare dei ruderi in un agriturismo. La popolazione locale però è ostile, in particolare due fratelli, proprietari della fattoria confinante. La tensione si trasforma in odio, l’odio in violenza. Nove premi Goya e definitiva consacrazione di Rodrigo Sorogoyen come autore cardine del nuovo cinema spagnolo, As Bestas è un western contemporaneo che sfocia nel dramma famigliare grazie a un sorprendente snodo narrativo che cambia radicalmente le prospettive dello spettatore. Da Cane di paglia derivano canovaccio, tema e caratterizzazioni, la gradualità inesorabile dell’assedio, mentre da John Ford il senso dell’insediamento, dell’avamposto civile in terra selvaggia oltre a luoghi/ambienti specifici (nel bar del paese tutto va come in un saloon) oltre alla relazione tra figura e paesaggio, sempre soverchiante a favore del paesaggio. Ovviamente, ancora di più, il discorso si complica quando si passa a confrontare le implicazioni ideologiche sottese. In questo senso, Sorogoyen mantiene il film fermo sulla contrapposizione che genera scontro, senza indagare troppo anche l’arroganza dei colti, progressisti émigré francesi, indifferenti alle sofferenze di una popolazione locale povera e incattivita. Nonostante la rigidità un po’ anacronistica che divide i suoi protagonisti in buoni e cattivissimi, As Bestas è uno dei thriller più solidi e meglio costruiti degli ultimi anni. Una lectio magistralis nella gestione della tensione e sulla possibilità di ricodificare in maniera efficace gli stilemi del cinema western tradizionale.

Il Ragazzo e l’Airone
Enigmatico e inafferrabile, Il Ragazzo e l’Airone scava nelle memorie ancestrali del maestro dell’animazione giapponese, che, completamente libero dai lacci della sceneggiatura, lascia correre la sua immaginazione affidandosi esclusivamente al proprio miracoloso intuito per le immagini. Hayao Miyazaki firma così una versione maschile e pessimista de La Città Incantata, di cui riprende temi e persino alcune delle soluzioni visive più famose. A differenza delle tribolazioni della piccola Chihiro, però, quelle di Mahito restano lontane dal condurre alla presa di consapevolezza con cui tipicamente si concludono i racconti di crescita ed elaborazione del lutto, ma delineano un’emancipazione più problematica, in cui lo sradicamento e il sentimento di abbandono non si risolvono in una ricomposizione totalmente felice. Alla domanda che viene posta nel meraviglioso titolo giapponese - “E voi, come vivrete?” (dopo ciò che avete visto e vissuto, è il sottotesto) - non viene mai data risposta ed è anzi lo stesso spettatore a rivolgere il quesito a sé stesso dopo la visione di un film con cui è molto più difficile “empatizzare” rispetto ai classici Ghibli, che finisce senza spiegare cosa il suo eroe abbia appreso dal viaggio che ha appena compiuto. Un’opera che lascia al pubblico il compito di analizzare autonomamente le sensazioni e le riflessioni suscitate da un racconto così scostante, indagare significato di immagini mai univocamente date. Tutto, ne Il Ragazzo e l’Airone, affronta un passaggio da dentro a fuori - dal “dentro” del mondo fantastico al “fuori” del mondo reale, in un costante movimento di esondazione e tracimazione (dalle viscere, dalle acque ecc.) - ed è sottoposto ad una gravità che spinge le immagini a crollare su loro stesse, rendendo difficoltosa qualsiasi traiettoria di ascensione. Dentro e fuori lo schermo, quindi, in un ridimensionamento dell’opera cinematografica che, una volta consegnata all’esterno, si sgonfia, si rimpicciolisce, si “normalizza” rispetto alle ambizioni del suo creatore.
Leggi QUI la recensione completa.
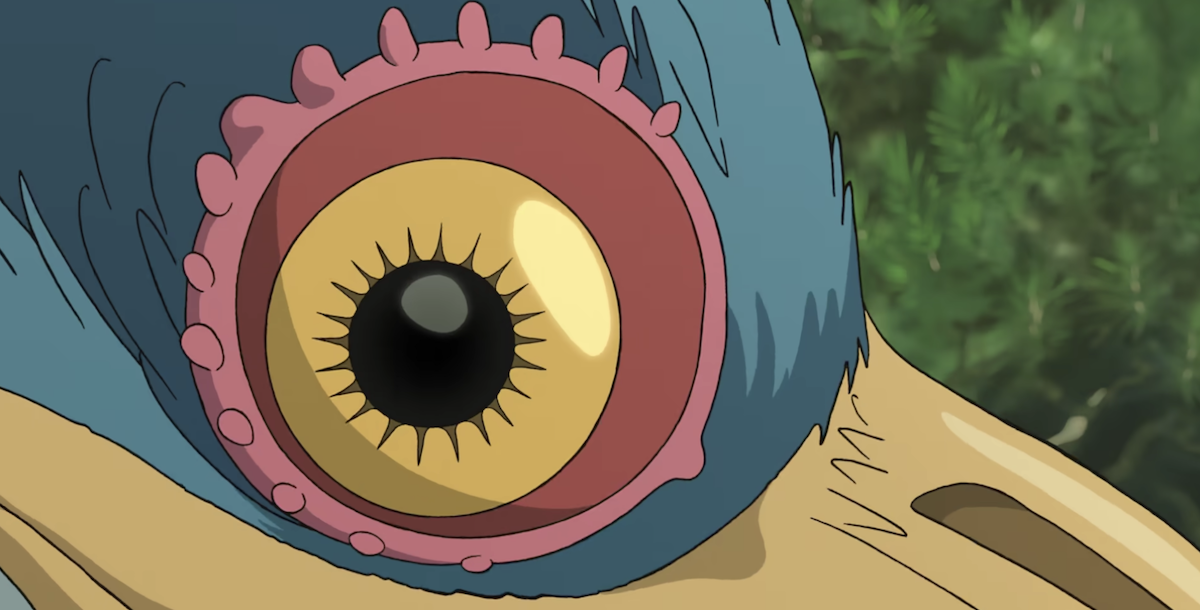
Pearl
Mia Goth (qui anche co-sceneggiatrice e produttrice) torna nel ruolo di Pearl nel nuovo film di Ti West, prequel dell’acclamato X - A Sexy Horror Story, mettendone in scena la giovinezza nel 1918. Prima con grande pudore, cercando di essere la persona che sua madre vorrebbe che fosse, che il suo sposo, lontano a causa della guerra, vorrebbe che fosse, che i film e la società di quel periodo vorrebbero che fosse. E poi sempre di più allontanandosi da quei modelli che non sono i suoi e lasciandosi vincere dalle pulsioni violente che non riesce a trattenere, aggravate da una solitudine estrema imposta dalla diffusione dell’influenza spagnola, che costringe la ragazza a casa insieme alla severissima madre e al padre ormai immobile e (apparentemente) incosciente. I problemi di Pearl si fanno sempre più visibili a causa di questa lontananza dalle altre persone, al punto da rendere quello di Ti West il miglior horror (ad oggi) realizzato sul lockdown e sulle sue conseguenze, sulla paura di non poter mai più uscire da quell’isolamento o, peggio, di uscirne e scoprire che si è rimasti indietro rispetto a tutti gli altri (non a caso il film è stato pensato durante il periodo di stop alle produzioni causato dal Covid). Il vero obiettivo di Pearl è però un altro ed è quello di far cambiare il giudizio dello spettatore su quanto raccontato nel film originale ambientato alla fine degli anni Settanta. Quell’ageismo che permeava X trova, alla luce di questo prequel, un senso tutto diverso, riconfigurandosi come il culmine di una lunga esistenza trascorsa perennemente bramando il piacere fisico senza mai ottenerlo. Pearl, di fatto, finisce quindi per migliorare X essenzialmente svelando tutte le carenze e la repressione che hanno fatto impazzire la donna di cui raccontava quel film, restituendo profondità psicologica ad un personaggio che prima non ne aveva.

My Love Affair with Marriage
Con My Love Affair with Marriage, l’animatrice lettone Signe Baumane crea un’altra densa narrazione personale in grado di esprimere concetti e idee complicate in immagini. Pieno di ironia, umorismo, riferimenti alla storia sovietica e numeri musicali, il suo ambizioso secondo lungometraggio (dopo il successo festivaliero di Rocks In My Pockets) è un’affollata cacofonia di voci e volti: 30 sono i personaggi che cantano e parlano (tra cui un neurone parlante che spiega i processi biochimici del cervello) e circa 200 non parlanti. Utilizzando personaggi disegnati a mano animati su set 3D artigianalmente ricostruiti e sculture di cartapesta, fonde il racconto di formazione di una giovane ragazza sovietica indipendente e appassionata di arte con un resoconto dei processi biochimici che avvengono nel suo corpo nei momenti cruciali della sua vita (e quindi della narrazione del film). I messaggi – palesi e subliminali – che Zelma riceve dalla sua famiglia e dalle istituzioni sovietiche sul ruolo e i doveri di una donna sono piuttosto tipici per una giovane ragazza del suo tempo, in quel contesto storico-geografico. Ciò che è unico in questa storia, tuttavia, è il modo in cui Baumane mostra la maniera in cui queste convenzioni sociali interagiscano con la biologia e la chimica più intime della protagonista, mettendo in scena un discorso complesso e intelligente che non sarebbe stato possibile articolare con altri strumenti al di fuori dell’animazione.

Anatomia di una caduta
Un uomo muore, una donna gli sopravvive e viene subito accusata del suo possibile omicidio, essendo l’unica adulta in casa in quel momento. È una donna emancipata e decisamente poco “calorosa”, lontanissima dall’idea tradizionale di madre. Ha spesso demandato al marito le incombenze domestiche e la cura del figlioletto per occuparsi della sua carriera. Scelta di emancipazione per cui il compagno - frustrato da alcuni problemi personali - dimostrava insofferenza. Era depresso (sottinteso nella misoginia ordinaria che guida le accuse: la moglie era la causa della sua depressione)? Si è ucciso o è stato ucciso, cambia davvero qualcosa? O meglio, cambia davvero ai fini della distribuzione della colpa, già assegnata ancora prima di entrare in tribunale? Il processo che lo deve stabilire è alla base di quello che non è solo un thriller giudiziario, ma piuttosto l’analisi di un’idea di donna, delle aspettative che più o meno consciamente riponiamo nella figura femminile nel nucleo famigliare. Justine Triet domina il dramma processuale (nuovo genere d’elezione del cinema d’autore francese, dopo Le Procès Goldman di Cédric Kahn e Saint Omer di Alice Diop) non tanto per giocare con la suspense, quanto per mettere a fuoco il suo stile, che non è mai sembrato così vicino ad una forma di perfezione, in cui il caos che è stato il segno distintivo dei suoi precedenti film viene qui contenuto nella precisione del dispositivo. Non riusciamo spesso ad ascoltare le frasi lasciate a metà, tagliate in volo, a cui si impedisce di atterrare nell’inquadratura successiva, rubate alle nostre orecchie e a quelle dei personaggi, che si parlando senza mai capirsi o ascoltarsi. A dire il vero, le parole non possono fare molto. Solo i sensi sembrano in grado di contemplare una verità indicibile: il tocco di un ragazzino ipovedente (il formidabile Milo Machado Graner), l’istinto di un cane, l’ascolto della musica che viene fuori dalle note di una partitura pianistica non del tutto decifrata.

The Holdovers
Nel 1970, con l’avvicinarsi del Natale, alcuni studenti di un liceo maschile del Massachusetts sono costretti a trascorrere le vacanze in collegio, impossibilitati a tornare dalle loro famiglie per i motivi più differenti. Un professore di storia antica, atrabiliare e ampolloso (Paul Giamatti, nel ruolo della sua carriera), punito per essere stato troppo intransigente con il figlio di uno dei donatori più generosi, ha il compito di tenerli d’occhio, in compagnia solo di una cuoca, che ha appena perso il suo unico figlio nella guerra del Vietnam, e di una governante. Ancora una volta, fondamentalmente, il cinema di Alexander Payne si riconfigura come buddy movie in cui due figure opposte (l’insegnante anaffettivo e lo studente problematico) finiscono per convivere. Se gli anni Settanta erano l’orizzonte estetico e politico di Sideways, adesso fanno da ambientazione al primo film in costume di Payne, capace, insospettabilmente, di elevare le questioni di classe allo stesso livello di quelle di razza (una sfida nel cinema americano contemporaneo). The Holdovers non sembra solo ambientato nel 1970, ma sembra effettivamente prodotto e realizzato in quegli anni, anche se in una maniera stranamente “truffaldina”. Girato in digitale e poi ritoccato in post-produzione per ricreare un look vintage, Payne sembra denunciare l’impossibilità per un film del genere di esistere oggi alla luce delle moderne logiche di mercato e della mutata sensibilità del pubblico, suggerendo come l’unico modo per raccontare una storia di questo tipo, in questa maniera, con questi sentimenti e questi personaggi, sia quella di camuffarla da operazione nostalgia dolcemente fuori dal tempo. Una commedia drammatica per adulti, triste ma anche rassicurante, che non cerca mai di essere troppo ambiziosa o monumentale, ma nemmeno si concede alcuna leggerezza o sbavatura, affidandosi ad un cast sorprendente e diretto da un regista in stato di grazia. Un film da maglione di lana, tazza di cioccolata calda e legna che brucia, che certifica però una verità fondamentale: che tutti là fuori hanno una storia che vale la pena conoscere e con la quale ci si può immedesimare al di là del tempo, del contesto e degli accadimenti. Ci vuole solo l’abilità di qualcuno che la sappia raccontare.

Il male non esiste
Il giapponese Ryusuke Hamaguchi è ormai diventato uno dei registi di culto della sua generazione, capace, ad ogni film, di riorganizzare gli strumenti a sua disposizione con risultati sempre nuovi e sorprendenti. Il male non esiste contiene sequenze inaspettatamente estese di guida, discussioni di gruppo (sull’impatto locale del glamping!), la solita atmosfera placida ma enigmatica dei suoi precedenti lavori: tutti elementi già noti, ma che qui, nel contesto di una “cautionary tale” che mette in evidenza la fragilità degli ecosistemi locali (sia dal punto di vista ambientale che sociale), assumono un altro senso e vengono utilizzati per raggiungere obiettivi differenti. Da idillio bucolico su quanto sia gratificante la vita nei piccoli villaggi di campagna, le tensioni latenti nel film cominciano pian piano a creare delle piccole fratture e ad incrinare le situazioni consolidate, determinando un crollo improvviso di tutto ciò che si stava costruendo in termini di relazioni e tessitura di una rete solidale tra amministrazione e comunità. Il tono del racconto cambia nel momento in cui la prospettiva passa bruscamente da quella di un abitante del villaggio a quella di un burocrate - curioso e disponibile al confronto e non macchiettisticamente disinteressato alla vicenda - a cui è stato assegnato il compito di convincere la popolazione locale della bontà dei progetti imposti dall’alto. Hamaguchi riesce a mantenere uno stranissimo equilibrio tra l’inchiesta quasi documentaristica (essendo questo un film apparentemente molto meno “filosofico” e di elucubrazione intellettuale di quanto non lo fosse Drive My Car) e il fascino misteriosamente metafisico di un mondo che sembra non essere comprensibile con la razionalità, figuriamoci con la burocrazia.

Il cielo brucia
Se la protagonista di Undine era una donna passionale, di energia travolgente e disarmante, qui Nadja, unica figura femminile di un atipico e sbilanciato ménage à trois (poi sempre più numeroso), è più tenera, apparentemente più gioiosa e rassicurante, pur nelle sue ombre e nei suoi non detti. Corrispettivo ideale di un protagonista maschile che, invece, è totalmente immerso nella propria dimensione iperuranica: così avvitato su sé stesso da non rendersi conto di ciò che gli accade attorno, cieco persino davanti alle più lapalissiane evidenze. È infatti l’unico personaggio del film a non vivere veramente e a desiderare senza possedere, demandando al mondo dell’immaginazione l’appagamento di un desiderio vago, mai realmente circostanziato, laddove invece gli altri personaggi sono presenze vive e attive. È uno scrittore - cosa ricorrente nel cinema metalinguistico e antipsicologico di Christian Petzold - ed è proprio il suo ostentato e asfissiante egocentrismo ad impedirgli di comprendere e decodificare la realtà in cui si muove e le persone con cui si relaziona. Per quanto si possa essere attenti ai propri movimenti interiori, alla propria psicologia, di cosa si può davvero scrivere se non si è in grado di aprire gli occhi sugli altri e sul mondo, anche solo per registrare la vita che accade? È la gigantesca domanda che pone questo stranissimo dramma che finge all’inizio di essere una commedia sentimentale, investendo in una cifra più ironica rispetto al passato, a cui contribuisce non poco lo stesso Thomas Schubert, che conferisce a Leon una fisicità impacciata, a tratti irresistibile. Su di lui, per tutta la prima metà del film, Petzold sembra costruire un altro tipo di racconto, uno con al centro un maschio goffo, permaloso, incapace di gestire le cose e le situazioni, di relazionarsi con l’altro sesso, fino a manifestazioni conflittuali piuttosto infantili. Ma è un inganno che viene progressivamente smascherato, nel momento in cui anche la regia smette di assecondare il solipsismo del proprio protagonista, per allargare finalmente lo sguardo e dire una cosa molto precisa: che il mondo là fuori è in fiamme e siamo forse tutti un po’ troppo occupati a riflettere su noi stessi, sulle nostre private e banali insoddisfazioni, per agire e spegnere l’incendio.

The First Slam Dunk
The First Slam Dunk è innanzitutto un grande film sul basket, ma anche una riflessione sull’intensità fisica, sullo sforzo agonistico e sulla sua rappresentazione. Sport e cinema trovano una drammaturgia comune, qui data dall’animazione, da una bellezza plastica che aggiunge consistenza al disegno e che chiede di essere osservata e analizzata, fino ad un finale sperimentale e inedito (bianco e nero, assenza di audio, glitch visivi ecc.), sinestetico, quasi orgasmico. “Questo suono mi farà sempre risorgere”, dice l’eroe nel momento in cui la rete viene strofinata dalla palla che entra nel canestro. Takehiko Inoue si fa cineasta alla maniera di Katsuhiro Otomo prima di lui, ma invece di limitarsi alla semplice traduzione del suo lavoro da un medium all’altro, usa gli strumenti propri del cinema per dire qualcosa di diverso a partire dalla stessa storia: mette in panchina la sua stella più brillante (il protagonista del manga) e gli preferisce il discreto compagno di squadra, Miyagi Ryota, appesantito dal fantasma di un fratello leggendario a cui non smette mai di paragonarsi. Cambiando il punto di vista, Inoue getta Slam Dunk nel dramma, in un’interiorità irradiante che organizza piccole isole di tristezza e dubbio che inframmezzano le due ore del match raccontato dal film. Intermezzi in cui ciascun ragazzino si interroga su chi sia, dentro e fuori dal campo, e cerca nelle braci del fuoco che lo anima qualcosa che lo accenda un’ultima volta sul campo.
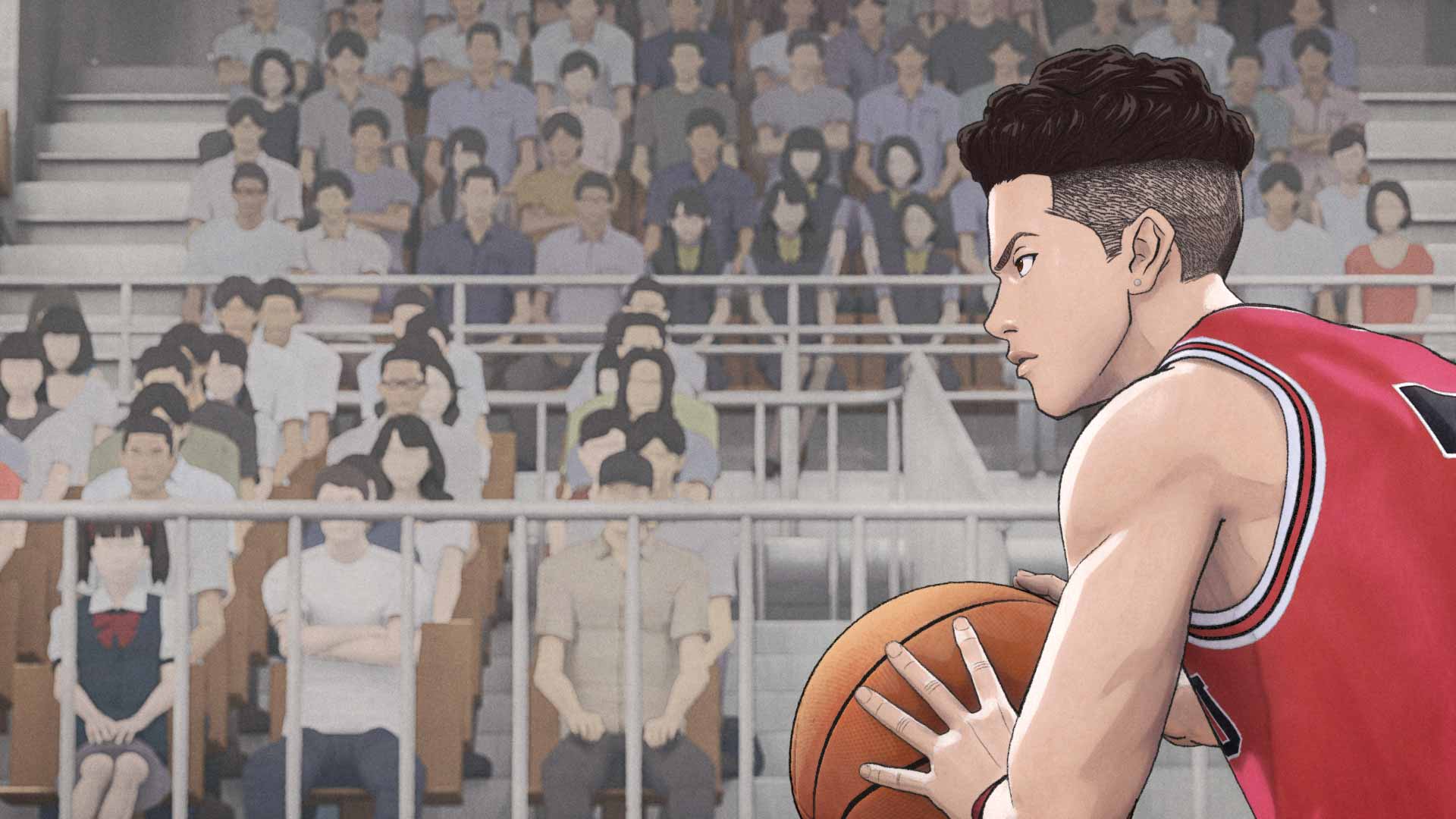
Perfect Days
Era il 1985 quando Wim Wenders si avventurò per la prima volta in un Giappone che sembrava una possibile invenzione di futuro, in quello che rimane fra i suoi film più belli: Tokyo-Ga, omaggio al cinema dell’amato Ozu, racconto di un mondo che si dischiudeva frenetico e misterioso davanti ai suoi occhi già abituati a quel paesaggio dall’immaginario cinematografico precedentemente frequentato. Tornando a Tokyo, il cineasta tedesco sembra ancora una volta seguire la traccia mnesica di Ozu, lasciando però quasi completamente fuori campo il flusso metropolitano del presente per rendere ancora più evidente quel che rimane del cinema del suo maestro quando lo si riduce all’essenzialità umana. Hirayama, il protagonista del film, lavora come inserviente nelle toilette pubbliche, sempre immacolate, fa il suo lavoro con cura quasi maniacale, cosa che il giovane assistente non capisce, dal momento che - gli fa notare - saranno presto nuovamente luride. Ma lo scrupoloso addetto alle pulizie, un Jeanne Dielman al maschile, caratterizzato dal rituale meccanizzato che compie instancabilmente, sembra volersi seriamente prendere cura di quei “luoghi tranquilli” che sono i bagni pubblici delle città giapponesi, come già indicato in un illuminante saggio da Peter Handke (che con Wenders ha scritto pagine di cinema indimenticabili). Gli unici luoghi in cui ci si può percepire effettivamente atterrati sull’isola, angusti osservatori dai quali ci si può impossessare di un Paese intero. Il rinchiudersi, l’isolarsi, viene quindi ricodificato non come atto antisociale, ma come possibilità di riconciliarsi con i rumori del mondo di fuori - i camion, i tram, persino le sirene dell’ambulanza o della polizia - che, penetrando all’interno attraverso le pareti e le finestre, riportano indietro dagli altri con una maggiore serenità e consapevolezza. È nel Luogo Tranquillo pubblico o semipubblico che, scrive Handke, “si può sempre approdare a una qualche intuizione, osservazione e, alla fine, ad una riflessione”.

La chiamata dal cielo
Girato in Kirghizistan nel 2019, concluso e montato da amici e colleghi, Call of God è l’ultimo film di Kim Ki-duk, scomparso nel dicembre 2020 all’età di 59 anni. Un dono postumo e inatteso, su cui occorre bilanciare il giudizio e tener conto delle difficoltà di budget incontrate dall’autore, alle prese con una profonda crisi personale e professionale. Al centro c’è ancora una volta una relazione tormentata e distruttiva, che il regista coreano declina come sempre nel sesso e nella perversione, nella possessività malata e nell’autolesionismo. Ci si potrà soffermare sulla misoginia del punto di vista, sulla fragilità e ambiguità di molti passaggi di sceneggiatura, e non sarebbe ingiusto farlo, anche perché tutto il film appare come un doloroso tentativo di introspezione senza giustificazioni né filtri, come lascia intuire l’incipit: una frase dello stesso Kim Ki-duk sugli errori del passato e l’impossibilità di intervenire sul Tempo. Un’opera che sembra gettarsi in pasto alle critiche e che scopre il fianco per mostrare tutta la sua problematicità. Nonostante ciò, quel modo di procedere unico che ha reso grande il cinema di Kim Ki-duk è più presente qui che in altri suoi lavori dell’ultimo periodo realizzati in maniera più professionale come Il prigioniero coreano. Questo film postumo svela in più punti il tema di base di tutto il cinema di questo regista, cioè la maniera in cui la luce e l’oscurità debbano essere considerati fasi di uno stesso movimento vitale, che tiene insieme la violenza e la ferocia con i loro opposti.

Skinamarink
Kevin e Kaylee sono due bambini di quattro anni che si risvegliano completamente soli nella casa in cui vivono. Alle pareti sono scomparse le porte d’ingresso e le finestre, così ai due non resta che aspettare il ritorno dei genitori guardando i cartoni animati in televisione. Ma qualcosa si nasconde nel buio della loro abitazione e una misteriosa voce comincia ad attirarli verso la cantina. Skinamarink è leggero nella trama e ancora più leggero nel movimento della macchina da presa. È fatto interamente di immagini oscure e sgranate che chiedono allo spettatore una decodifica fulminea, prima che il soggetto cambi nuovamente e una nuova ombra sul muro compaia ad annunciare una successiva minaccia. Un film che opera nelle maglie del found footage horror ma libera il classico dispositivo POV dall’aderenza all’obiettivo di una camera per farsi invece soggettiva dell’infanzia, rapsodica visione del buio che attinge alla madre di tutte le paure, ovviamente radicata nel rapporto con i propri genitori e la famiglia: la sensazione terribile di essere abbandonati, la scoperta della solitudine nella realtà limitale tra sonno e veglia.

Silent Night
Privo di qualsiasi dialogo, il nuovo film di John Woo è l’omaggio più sentito che il regista potesse fare al suo mentore Chang Cheh: cineasta instancabile con più di 90 titoli all’attivo, uomo chiave dell’impero dello Studio Shaw, capace di dirigere dai quattro ai sei film all’anno all’apice della sua carriera. È lui ad aver lanciato tutti i nomi fondamentali del cinema di Hong Kong degli anni 70 - Jimmy Wang Yu, Ti Lung, David Chiang, Alexander Fu Sheng, Gordon Liu, Lau Kar Leung, Lo Lieh e, ovviamente, John Woo - oltre ad aver diretto revenge movie quintessenziali come Mantieni l’odio per la tua vendetta, primo capitolo della trilogia dello spadaccino monco, a cui questo Silent Night sembra rifarsi sfacciatamente. Action movie di cui rimane solamente l’osso, mettendo in scena la rocambolesca e sanguinosa coreografia da cinema muto di un uomo solo (o meglio, che lo diventa a causa delle sue ossessioni di vendetta) senza parole, “monco” della voce e della possibilità di esprimersi con altro rispetto ai propri gesti. Tutto ciò che deve comunicare, lo comunica con il proprio corpo. Corpo filmico per eccellenza, sul quale avvengono tutti i passaggi tipici del genere, fino ad un finale fatalista che ammette la totale stupidità di intenti di ogni giustiziere fai-da-te.

Yannick
Il nuovo film di Quentin Dupieux è arrivato nelle sale francesi dopo essere stato annunciato quasi di soppiatto un paio di settimane prima dell’uscita, in un tempo in cui spesso le campagne marketing contano più di ciò che sponsorizzano e vengono preparate con anni di anticipo. Un atto di coraggio che - come tutte le cose pensate da Dupieux - è già di per sé contraddittorio: da un lato segna la volontà di lasciare spazio all’opera, oscurando il suo autore (non è un caso che abbia cominciato la sua carriera sotto pseudonimo) e impedendogli di fare adeguata promozione al film, dall’altro finisce per essere una prova muscolare che dimostra come oggi, almeno in Francia, l’ex Mr. Oizo non abbia bisogno di presentazioni o di stratagemmi commerciali per attirare l’attenzione del pubblico. Yannick comincia, come da manuale Dupieux, da una premessa che poi diventa il film stesso: in questo caso uno spettatore sempliciotto, estraneo a qualsiasi dibattito culturale, anche quello più pop (lo spettatore medio fuori dalla bolla degli appassionati?) durante la rappresentazione di una commedia teatrale si alza in piedi e protesta per il fatto che questa non lo faccia abbastanza ridere. Prenderà in ostaggio (letteralmente) la sala e gli attori sul palco e cercherà di correggere lo spettacolo (Le Cocu, “l’essenza stessa del vaudeville”) a modo suo, come in un desiderio di rivoluzione dal basso delle convenzioni - spesso tiranniche - che regolano l’intrattenimento. Dupieux (in una normalizzazione che, contrariamente a ciò che solitamente accade, ha giovato alla godibilità del suo cinema) riflette così sul pericolo che rappresenta l’assottigliarsi del confine tra il pubblico e l’autore, ma anche su quella che è da sempre la sua più grande paura: annoiare chi va a vedere i suoi film e “rubare tempo prezioso” allo spettatore. E infatti anche questo nuovo Yannick dura appena 67 minuti, pieni di eccezionali trovate estemporanee e del suo solito gusto per l’incongruenza logica.

Decision To Leave
Il nuovo film di Park Chan-wook è un thriller-melò pensato già montato, che con apparente facilità riesce a trovare tantissimi modi diversi per mettere in relazione i suoi due protagonisti, creando una narrazione ellittica che si fa sempre più breve e incalzante, che riduce progressivamente le distanze temporali e spaziali, riuscendo ad ottenere una contemporaneità e una compresenza che, malinconicamente, suggeriscono il loro esatto opposto: il continuo sfiorarsi e mancarsi di due amanti che non riescono mai davvero a trovare un loro modo di stare insieme. Decision to Leave si vuole lontano dal genere poliziesco tradizionale e nel farlo trova un nuovo percorso, ingarbugliato e assolutamente non-lineare, per arrivare agli stessi obiettivi del cinema più classico. Lo spettatore, come il detective che usa il collirio prima di analizzare la scena del crimine, è chiamato ad uno sforzo di osservazione che però non è mai faticoso, ma ludico, in cui ogni nuovo tassello che si riesce ad inserire è una ricompensa per l’attenzione ricevuta. Chi guarda si deve orientare in un racconto che cambia continuamente tono e atmosfera, che comincia come una screwball comedy e poi man mano si svuota della propria ironia, elimina i comprimari che svolgono la funzione di intermezzo comico, tagliando definitivamente le scene in cui sono presenti, come se il montaggio, nella sua furia di avvicinamento e contrazione, non possa più concedere spazio a ciò che non riguarda direttamente questa donna dall’avvenenza gentile, in grado di essere attraente senza dover fare nulla.
Leggi QUI la recensione completa.

Godzilla Minus One
In Godzilla Minus One il kaiju non è più solamente una conseguenza dei test delle bombe atomiche: questa volta Godzilla è l’atomica stessa. La distruzione delle città che attraversa è messa in scena con tutte le convenzioni cinematografiche con cui generalmente si racconta della distruzione causata da una bomba sganciata dal cielo. Lo scenario di devastazione che il film ci consegna è in tutto e per tutto uguale a quello che si avrebbe dopo l’esplosione di un’atomica e di questo il film parla: della disperazione della popolazione rispetto a quegli avvenimenti storici, delle colpe degli Stati Uniti e del governo giapponese, che avrebbe lasciato solo il suo popolo all’indomani della catastrofe, abbandonandolo a sé stesso. Una catastrofe arrivata a colpire un Paese già sconfitto, devastato, impegnato ancora a piangere i caduti in battaglia e a seppellire i propri cari. La metafora viene utilizzata in maniera efficacissima, non limitandosi stavolta a far coincidere il mostro con un incubo collettivo, ma rendendolo anche simulacro dei demoni privati del protagonista, con cui finalmente possiamo empatizzare: un soldato pieno di sensi di colpa perché ha scelto di non morire per quella che considerava una causa persa (la guerra, come tutte le guerre, ci dice quello che forse è il film più esplicitamente e genuinamente antibellicista degli ultimi anni), che sente di dover affrontare Godzilla per meritare una nuova vita. Affrontarlo e magari sconfiggerlo, riconsegnando così al kaiju quel suo fascino ambivalente di arma inconsapevole, di sciagura provocata da errori umani che, in ogni caso, si può combattere e vincere (a differenza di un’atomica). In superficie, Godzilla Minus One è un blockbuster entusiasmante che funziona contemporaneamente sia come spettacolo d’azione epico che come dramma emotivo. Ma ad un livello più profondo, agisce come confutazione filosofica della nozione antiquata del Giappone come culla di un eroismo militare sacrificale, che stavolta non ha proprio nulla di coraggioso, romantico o glorioso.

Passing Time - Terence Davies
Lo scorso 15 settembre, l’International Film Fest Gent ha celebrato la sua 50esima edizione con il progetto 2×25, abbinando 25 registi con 25 compositori provenienti da tutto il mondo per la realizzazione di cortometraggi inediti, la maggior parte della durata di soli due o tre minuti, che sono stati poi pubblicati su YouTube. Appena tre settimane dopo, il regista del migliore di questi film, il grandissimo Terence Davies, ci avrebbe lasciato all’età di 77 anni. Nato dalla collaborazione con la compositrice uruguaiana Florencia Di Concilio, quello che è probabilmente l’ultimo lascito di Davies è un piccolo film lussureggiante e malinconico, costituito da un unico fotogramma, orlato da foglie tremolanti, che trattiene l’immagine di un campo vicino alla casa del regista nell’Essex. Ad accompagnare la composizione per archi di Di Concilio, c’è la voce eloquente ma incerta dello stesso Davies, che legge i versi di una sua poesia floridamente romantica ed emotivamente devastante che sembra anticipare il nostro dolore per la sua perdita: “For you are gone and not replaced / But echoes of your lovely self / Will bear us through life’s cruel stream”.
1967 - Pasolini in NYC
Nell’ambito della mostra Viva Varda!, in corso fino al 28 gennaio alla Cinémathèque française di Parigi, la piattaforma Henri ha reso pubblico un film fino a questo momento inedito della leggendaria cineasta francese, scomparsa nel 2019. Filmati nel 1966, questi magnifici 4 minuti e 20 secondi mostrano Pier Paolo Pasolini dietro ai suoi leggendari occhiali scuri camminare lungo la 42esima strada di New York. Su queste immagini è stata poi montata da Varda la traccia audio di un’intervista registrata da lei l’anno successivo, in cui Pasolini propone una propria riflessione sulla relazione tra realtà e finzione, sulla funzione del linguaggio audiovisivo nella società contemporanea e sulla potenza figurativa del suo cinema.
Winter Boy - Le Lycéen
Abbandonano progressivamente l’autofiction di Plaire, aimer et courir vite, adesso il cinema di Christophe Honoré, sublimato in questo bellissimo Le Lycéen, è agitato da un doppio movimento, introspettivo e allo stesso tempo totalmente aperto all’altro. Un ritratto che è sia autobiografico (del regista), quanto effettivamente cucito addosso ai suoi giovani protagonisti, raccontati nelle fragilità tipiche della loro generazione e mai giudicati con le convenzioni del passato, secondo gli schemi dell’adolescenza vissuta da chi li mette in scena. Gesto contemporaneamente di immedesimazione nell’altro e di autoanalisi, che viene chiesto anche agli stessi attori, abbastanza coraggiosi e bravi da accettare e indagare la vicinanza tra loro stessi e i personaggi che interpretano. Ricordando il dolore che lui stesso ha vissuto da adolescente omosessuale, Honoré spinge la tentazione di fare dell’autoterapia molto lontano, eclissandosi e programmando, nella veloce durata di una sequenza enigmatica, la sua “uscita di scena”, recitando nel ruolo di un padre che scompare improvvisamente senza avere la possibilità di dire addio alla sua famiglia. Una rimozione di sé dallo schermo molto significativa, che lascia lo spazio alla fiction e agli altri personaggi, in cui inevitabilmente quella presenza-assenza si riverbera e trova nuova amplificazione, nuova potenza espressiva.

Leila e i suoi fratelli
C’è una famiglia derelitta, composta da due genitori anziani, quattro fratelli cretini tra i 30 e i 50 anni e una sorella sola, Leila, l’unica con un po’ di intelletto, che tenterà disperatamente di sistemarli tutti in un delirio di corse, truffe, inganni, plagi e soprattutto furiose litigate domestiche che sono uno spasso prima che diventino un dramma. Dopo il trionfo mondiale di Parasite, adesso Leila’s Brothers si prende il medesimo rischio: quello di tentare la strada del cinema con un grandissimo appeal commerciale, capace di tenere un piede nella staffa del mainstream che parla a tutti e l’altro in quella del cinema più intelligente ed elevato. Eccezionale film iraniano con il ritmo del cinema internazionale, Leila e i suoi fratelli imbastisce una storia di famiglia con personaggi netti e chiari come nel cinema americano, presi però in una trama dalle morali ambigue e dotata di una visione ironica della miseria come il grande cinema italiano sapeva fare. Il poco più che trentenne Saeed Roustaee torna alle tematiche del suo esordio - giacché Life and a Day si dibatteva nel vuoto famigliare lasciato dalla fuga della figlia più giovane - e si concentra non solo su legami di sangue e relazioni affettive, non solo sulle ristrettezze economiche, bensì sul ruolo del patriarcato nel Paese persiano. Una storia estremamente locale scritta, recitata e messa in scena con tale perfezione da arrivare a tutti.

Gli spiriti dell’isola
Il termine inglese “nice”, nella sua evoluzione etimologica, non ha sempre significato la stessa cosa e non è sempre stato connotato da un’accezione positiva (quella di piacevole, cordiale, bello). Nel suo senso originale, infatti, era utilizzato come termine negativo di derivazione latina (da nescius, che voleva dire “inconsapevole, ignorante”), per poi essere ripreso con uguale valenza spregiativa nel francese del 1300 per indicare una persona “stupida o sciocca”. Ed è probabilmente a questo significato che si rifà il personaggio di Brendan Gleeson in The Banshees of Inisherin, silenzioso e taciturno suonatore di violino che improvvisamente decide che il suo migliore amico (Colin Farrell) non è più meritevole della sua compagnia proprio a causa della sua ostentata “niceness”, che non tollera più. Mutuando una delle idee principali della drammaturgia di Harold Pinter, il linguaggio vacuo e quotidiano utilizzato dai personaggi del film contiene una violenza latente, il desiderio soppresso di fare del male a qualcuno (o di farsi del male) appena si presenta l’occasione. È attraverso le parole, e soprattutto attraverso la loro continua reiterazione, che McDonagh costruisce la tensione (come avviene in un infuocato alterco condotto con un vocabolario limitato e giocato tutto su due sole parole: nice e dull). Una tensione che però non raggiunge mai immediatamente il proprio culmine, ma trova uno sbocco (generalmente sanguinoso) in ritardo. Le conseguenze delle azioni dei personaggi si rendono evidenti solo dopo ore dagli eventi che le hanno originate e la foga cieca e impulsiva che muove Pádraic e Colm rivela un’impreparazione a pensare in un orizzonte temporale futuro più lungo di un paio di giorni. Anche chi si dice desideroso di lavorare affinché qualcosa di lui arrivi alle generazioni successive, inevitabilmente finisce per radere al suono nel presente tutte le possibilità che potrebbero permettergli davvero di raggiungere quell’obiettivo. La sfida, tutta maschile, tra i due protagonisti del film è segnata fin dall’inizio dalla sconfitta di entrambi i contendenti.
Leggi QUI la recensione completa.

Comments